«Il Mattino del sabato», 10 novembre 1984 Nell’officina di Prisco: un collega, romanziere come lui, analizza il «metodo» di una narrativa che combina passato e presente, memoria e realtà, ina specialissima «sinossi» che si muove lungo un itinerario avvolgente teso a catturare la «qualità» dell’istante, Mario Pomilio
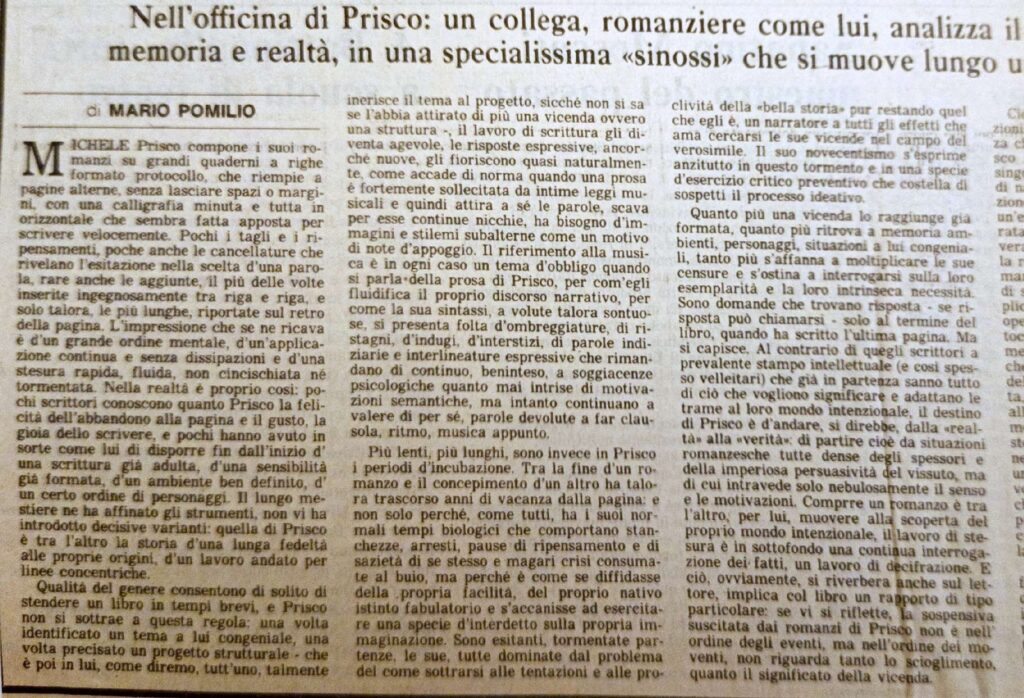
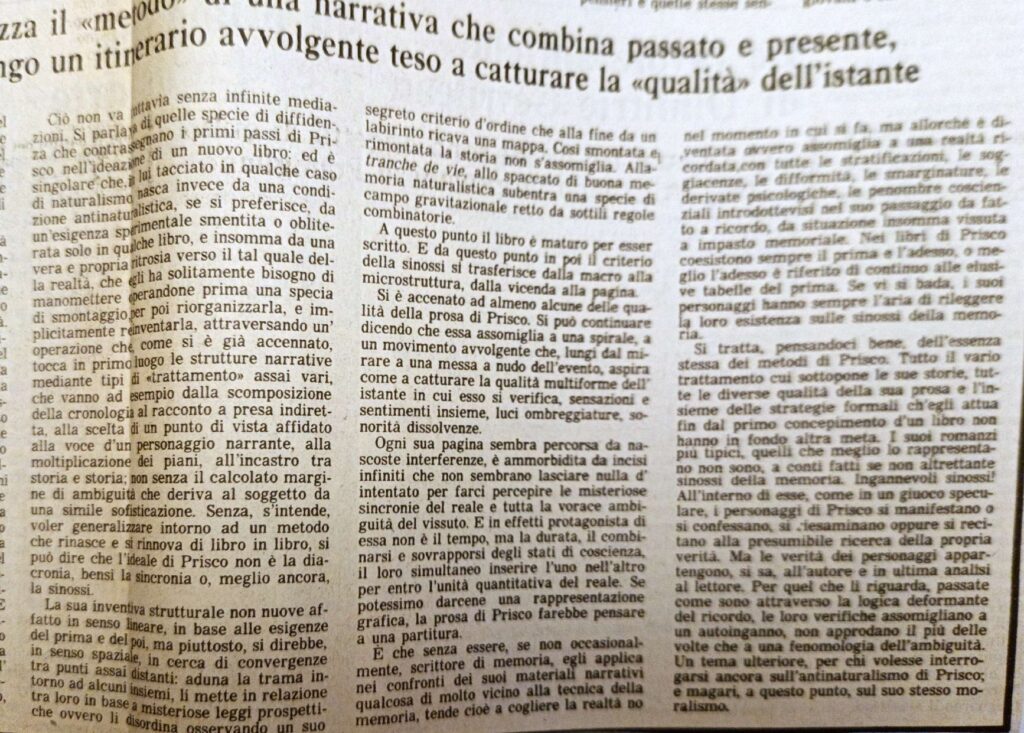
Michele Prisco compone i suoi romanzi su grandi quaderni a righe formato protocollo, che riempie a pagine alterne, senza lasciare spazi o margini, con una calligrafia minuta e tutta in orizzontale che sembra fatta apposta per scrivere velocemente. Pochi i tagli e i ripensamenti, poche anche le cancellature che rivelano l’esitazione nella scelta d’una parola, rare anche le aggiunte, il più delle volte inserite ingegnosamente tra riga e riga, e solo talora, le più lunghe, riportate sul retro della pagina. L’impressione che se ne ricava è d’un grande ordine mentale, d’un’applicazione continua e senza dissipazioni e d’una stesura rapida, fluida, non cincischiata né tormentata. Nella realtà è proprio così: pochi scrittori conoscono quanto Prisco la felicità dell’abbandono alla pagina e il gusto, la gioia dello scrivere, e pochi hanno avuto in sorte come lui di disporre fin dall’inizio d’una scrittura già adulta, d’una sensibilità già formata, d’un ambiente ben definito, d’un certo ordine di personaggi. Il lungo mestiere ne ha affinato gli strumenti, non vi ha introdotto decisive varianti: quella di Prisco è tra l’altro la storia di una lunga fedeltà alle proprie origini, d’un lavoro andato per linee concentriche.
Qualità del genere consentono di solito di stendere un libro in tempi brevi, e Prisco non si sottrae a questa regola: una volta identificato un tema a lui congeniale, una volta precisato un progetto strutturale – che è poi in lui, come diremo, tutt’uno, talmente inerisce il tema al progetto, sicché non si sa se l’abbia attirato di più una vicenda ovvero una struttura -, il lavoro di scrittura gli diventa agevole, le risposte espressive, ancorché nuove, gli fioriscono quasi naturalmente, come accade di norma quando una prosa è fortemente sollecitata da intime leggi musicali e quindi attira a sé le parole, scava per esse continue nicchie, ha bisogno d’immagini e stilemi subalterne come un motivo di note d’appoggio. Il riferimento alla musica è in ogni caso un tema d’obbligo quando si parla della prosa di Prisco, per com’egli fluidifica il proprio discorso narrativo, per come la sua sintassi, a volute talora sontuose, si presenta folta d’ombreggiature, di ristagni, d’indugi, d’interstizi, di parole indiziarie e interlineature espressive che rimandano di continuo, beninteso a soggiacenze psicologiche quanto mai intrise di motivazioni semantiche, ma intanto continuano a valere di per sé, parole devolute a far clausola, ritmo, musica appunto.
Più lenti, più lunghi, sono invece in Prisco i periodi d’incubazione. Tra la fine d’un romanzo e il concepimento d’un altro ha talora trascorso anni di vacanza dalla pagina: e non solo perché, come tutti, ha i suoi normali tempi biologici che comportano stanchezze, arresti, pause di ripensamento e di sazietà di se stesso e magari crisi consumate al buio, ma perché è come se diffidasse della propria facilità, del proprio nativo istinto fabulatorio e s’accanisse ad esercitare una specie d’interdetto sulla propria immaginazione. Sono esitanti, tormentate partenze, le sue, tutte dominate dal problema del come sottrarsi alle tentazioni e alle proclività della «bella storia» pur restando quel che egli è, un narratore a tutti gli effetti che ama cercarsi le sue vicende nel campo del verosimile. Il suo novecentismo s’esprime anzitutto in questo tormento e in una specie d’esercizio critico preventivo che costella di sospetti il processo ideativo.
Quanto più una vicenda lo raggiunge già formata, quanto più ritrova a memoria ambienti, personaggi, situazioni a lui congeniali, tanto più s’affanna a moltiplicare le sue censure e s’ostina a interrogarsi sulla loro esemplarità e la loro intrinseca necessità. Sono domande che trovano risposta – se risposta può chiamarsi – solo al termine del libro, quando ha scritto l’ultima pagina. Ma si capisce. Al contrario di quegli scrittori a prevalente stampo intellettuale (e così spesso velleitari) che già in partenza sanno tutto di ciò che vogliono significare e adattano le trame al loro mondo intenzionale, il destino di Prisco è d’andare, si direbbe, dalla «realtà» alla «verità» di partire cioè da situazioni romanzesche tutte dense degli spessori e della imperiosa persuasività del vissuto, ma di cui intravede solo nebulosamente il senso e le motivazioni. Comporre un romanzo è tra l’altro, per lui, muovere alla scoperta del proprio mondo intenzionale, il lavoro di stesura è in sottofondo una continua interrogazione dei fatti, un lavoro di decifrazione. E ciò, ovviamente, si riverbera anche sul lettore, implica col libro un rapporto di tipo particolare: se vi riflette, la sospensiva suscitata dai romanzi di Prisco non è nell’ordine degli eventi, ma nell’ordine dei moventi, non riguarda tanto lo scioglimento, quanto il significato della vicenda.
Ciò non va tuttavia senza infinite mediazioni. Si parlava di quelle specie di diffidenza che contrassegnano i primi passi di Prisco nell’ideazione di un nuovo libro: ed è singolare che in lui tacciato in qualche caso di naturalismo nasca invece da una condizione antinaturalistica, se si preferisce, da un’esigenza sperimentale smentita o obliterata solo in qualche libro, e insomma da una vera e propria ritrosia verso il tal quale della realtà, che egli ha solitamente bisogno di manomettere operandone prima una specie di smontaggio per poi riorganizzarla, e implicitamente reinventarla, attraversando un’operazione che, come si è già accennato, tocca in primo luogo le strutture narrative mediante tipi di «trattamento» assai vari, che vanno ad esempio dalla scomposizione della cronologia al racconto a presa indiretta, alla scelta di un punto di vista affidato alla voce d’un personaggio narrante, alla moltiplicazione dei piani, all’incastro tra storia e storia; non senza il calcolato margine di ambiguità che deriva al soggetto da una simile sofisticazione. Senza, s’intende, voler generalizzare intorno ad un metodo che rinasce e si rinnova di libro in libro, si può dire che l’ideale di Prisco non è la diacronia, bensì la sincronia o, meglio ancora, la sinossi.
La sua inventiva strutturale non nuove affatto in senso lineare, in base alle esigenze del prima e del poi, ma piuttosto, si direbbe, in senso spaziale, in cerca di convergenze tra punti assai distanti: aduna la trama intorno ad alcuni insiemi, li mette in relazione tra loro in base a misteriose leggi prospettiche ovvero li disordina osservando un suo segreto criterio d’ordine che alla fine da un labirinto ricava una mappa. Così smontata e rimontata la storia non s’assomiglia. Alla tranche de vie, allo spaccato di buona memoria naturalistica subentra una specie di campo gravitazionale retto da sottili regole combinatorie.
A questo punto il libro è maturo per esser scritto. E da questo punto in poi il criterio della sinossi si trasferisce dalla macro alla microstruttura, dalla vicenda alla pagina.
Si è accennato ad almeno alcune delle qualità della prosa di Prisco. Si può continuare dicendo che essa assomiglia a una spirale, a un movimento avvolgente che, lungi dal mirare a una messa a nudo dell’evento, aspira come a catturare la qualità multiforme dell’istante in cui esso si verifica, sensazioni e sentimenti insieme, luci ombreggiature, sonorità dissolvenze.
Ogni sua pagina sembra percorsa da nascoste interferenze, è ammorbidita da incisi infiniti che non sembrano lasciare nulla d’intentato per farci percepire le misteriose sincronie del reale e tutta la vorace ambiguità del vissuto. E in effetti protagonista di essa non è il tempo, ma la durata, il combinarsi e sovrapporsi degli stati di coscienza, il loro simultaneo inserire l’uno nell’altro per entro l’unità quantitativa del reale. Se potessimo darcene una rappresentazione grafica, la prosa di Prisco farebbe pensare a una partitura.
È che senza essere, se non occasionalmente, scrittore di memoria, egli applica nei confronti dei suoi materiali narrativi qualcosa di molto vicino alla tecnica della memoria, tende cioè a cogliere la realtà nel momento in cui si fa, ma allorché è diventata ovvero assomiglia a una realtà ricordata con tutte le stratificazioni, le soggiacenze, le difformità, le smarginature, le derivate psicologiche, le penombre coscienziali introdottivisi nel suo passaggio da fatto a ricordo, da situazione insomma vissuta a impasto memoriale. Nei libri di Prisco coesistono sempre il prima e l’adesso, o meglio l’adesso è riferito di continuo alle elusive tabelle del prima. Se vi si bada, i suoi personaggi hanno sempre l’aria di rileggere la loro esistenza sulle sinossi della memoria.
Si tratta, pensandoci bene, dell’esistenza stessa dei metodi di Prisco. Tutto il vario trattamento cui sottopone le sue storie, tutte le diverse qualità della sua prosa e l’insieme delle strategie formali ch’egli attua fin dal primo concepimento d’un libro non hanno in fondo altra meta. I suoi romanzi più tipici, quelli che meglio lo rappresentano non sono, a conti fatti se non altrettante sinossi della memoria. Ingannevoli sinossi! All’interno di esse, come in un giuoco speculare, i personaggi di Prisco si manifestano o si confessano, si riesaminano oppure si recitano alla presumibile ricerca della propria verità. Ma le verità dei personaggi appartengono, si sa, all’autore e in un’ultima analisi al lettore. Per quel che li riguarda, passate come sono attraverso la logica deformante del ricordo, le loro verifiche assomigliano a un autoinganno, non approdano il più delle volte che a una fenomenologia dell’ambiguità. Un tema ulteriore, per chi volesse interrogarsi ancora sull’antinaturalismo di Priaco; e magari, a questo punto, sul suo stesso naturalismo.
