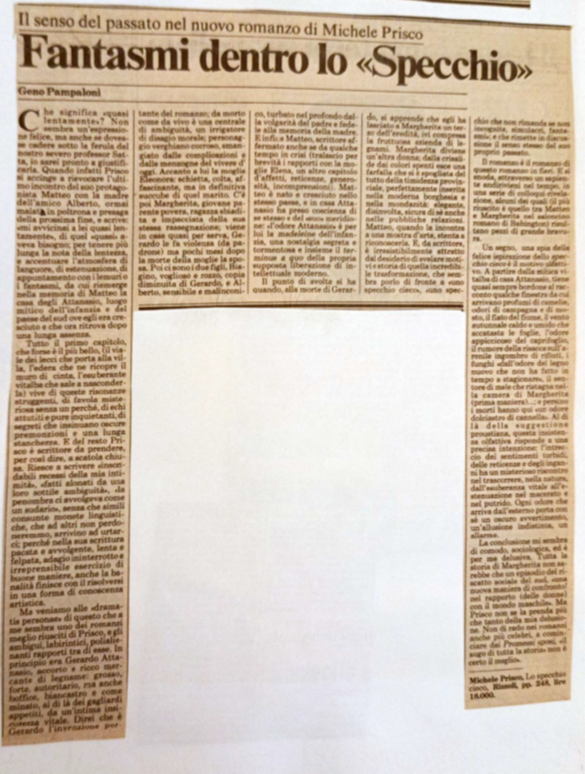«Il Giornale», 2 dicembre 1984, Fantasmi dietro lo “Specchio” Geno Pampaloni
Che significa “quasi lentamente”? Non sembra un’espressione felice ma anche se dovesse cadere sotto la ferula del nostro severo professor Satta, io sarei pronto a giustificarla. Anni infatti Prisco si accinge e arrivo vocare l’ultimo incontro del suo protagonista Matteo con la madre dell’amico Alberto, ormai malata in poltrona e presaga della prossima fine, e scrive: “voi mi avvicinai a lei quasi lentamente”, di quel “quasi” aveva bisogno; voi per tenere più lunga la nota della lentezza , e accentuare l’atmosfera di languore di estenuazione, di appuntamento con i lemuri o i fantasmi, da cui riemerge nella memoria di Matteo la casa degli Attanasio luogo mitico dell’infanzia e del paese del Sud ove egli era cresciuto e che ora ritrova dopo una lunga assenza.
Tutto il primo capitolo, che forse è il più bello, (il viale dei lecci che porta alla villa l’edera che ne ricopre il muro di cinta, l’esuberante vitalba che sale a nasconderla) vive di queste risonanze struggenti, di favola misteriosa senza un perché, di echi attutiti e pure inquietanti, di segreti che insinuano oscure premonizioni e una lunga stanchezza. E del resto Prisco è scrittore da prendere, per così dire, a scatola chiusa. Riesce a scrivere “insondabili recessi della mia intimità”, “fatti alonati da una loro sottile ambiguità”, “la penombra ci avvolgeva come un sudario”, senza che simili consunte monete linguistiche, che ad altri non perdoneremmo, arrivino ad urtarci; perché nella sua scrittura pacata e avvolgente, lenta e felpata adagio ininterrotto e irreprensibile esercizio di buone maniere, anche la banalità finisce con il risolversi in una forma di conoscenza artistica.
Ma veniamo alle “dramatis personae” di questo che a me sembra uno dei romanzi meglio riusciti di Prisco, e gli ambigui, labirintici, polialienanti rapporti tra di esse. In principio era Gerardo Attanasio, accorto e ricco mercante di legname: grosso, forte, autoritario, ma anche boffice, biancastro e come minato, al di là dei gagliardi appetiti, da un’intima insicurezza vitale. Direi che è Gerardo l’invenzione portante del romanzo; da morto come da vivo è una centrale di ambiguità, un irrigatore di disagio morale; un personaggio verghiano corroso, smangiato dalle complicazioni e dalle menzogne del vivere d’oggi. Accanto a lui la moglie Eleonora: schietta, colta, affascinante, ma in definitiva succube di quel marito. C’è poi Margherita, giovane parente povera, ragazza sbiadita impacciata della sua stessa rassegnazione; viene in casa quasi per serva, Gerardo le fa violenza (da padrone) ma pochi mesi dopo la morte della moglie la sposa. Poi ci sono i due figli, Biagino, voglioso e rozzo, e Alberto, sensibile e malinconico, ma vattene nel profondo dalla volgarità del padre fedele alla memoria della madre. E infine Matteo, scrittore affermato anche se da qualche tempo in crisi (tralascio per brevità i rapporti con la moglie Elena, un altro capitolo d’affetti, reticenze, generosità, incomprensioni). Matteo è nato e cresciuto nello stesso paese , e in casa Attanasio ha preso coscienza di se stesso e del “suo” meridione; l’”odore Attanasio” è per lui la madeleine voi dell’infanzia, una nostalgia segreta e tormentosa e insieme il terminus a quo voi della propria supposta liberazione di intellettuale moderno.
Il punto di svolta si ha quando, la morte di Gerardo, si apprende no che gli ha lasciato a Margherita un terzo dell’eredità, ivi compresa la fruttuosa azienda di legnami. Margherita diviene un’altra donna; dalla crisalide dai colori spenti esce una farfalla che si è spogliata del tutto della timidezza provinciale, vita della moderna borghesia e nella mondanità: elegante, disinvolta, sicura di sè anche nelle pubbliche relazioni. Matteo, quando la incontra a una mostra d’arte, stenta a riconoscerla. E. da scrittore, e irresistibilmente attratto dal desiderio di svelare motivi storia di quella incredibili trasformazioni , che sembra porlo di fronte a “uno specchio cieco”, “1 uno specchio e non rimanda se non incognite, simulacri, fantasmi”; e che rimette in discussione il senso stesso del suo proprio passato.
Il romanzo è il romanzo di questo romanzo in fieri. E si snoda, attraverso un sapiente andirivieni nel tempo, in una serie di colloqui-rivelazione, alcuni dei quali (il più riuscito è quello tra Matteo e Margherita nel saloncino romano di Babington) risultano pezzi di grande bravura.
Un segno, una spia della felice ispirazione dello specchio cieco è il motivo olfattivo. a partire dalla mitica vitalba di casa Attanasio tiene quasi sempre bordone al racconto qualche finestra da cui arrivano profumi di camelie, odori di campagna e di mosto, il fiato del fiume, il vento autunnale caldo e umido che accatasta le foglie, l’odore appiccicoso del caprifoglio, il rumore della risacca sull arenile ingombro di rifiuti, i funghi “dall’odore del legno nuovo che non ha fatto in tempo a stagionare”, il sentore di mele che ristagna nella camera di Margherita (prima maniera)…; e persino morti hanno qui “un odore dolciastro di cannella”. Al di là della suggestione proustiana, questa insistenza olfattiva risponde a una precisa intenzione: l’intreccio dei sentimenti torbidi, delle reticenze e degli inganni ha un misterioso riscontro nel trascorrere, nella natura, dall’esuberanza vitale nell’estenuazione nel macerato e nel putrido. Ogni odore che arriva dall’esterno porta con sé un oscuro avvertimento, un’allusione indistinta, un allarme.
La conclusione mi sembra di comodo, sociologica, ed è per me diluitiva. Tutta la storia di Margherita non sarebbe che un episodio del riscatto sociale del Sud, “una nuova maniera di confronto! nel rapporto (delle donne) con il mondo maschile”. Ma Prisco non se la prenda più che tanto della mia delusione. Non di rado nei romanzi anche più celebri, a cominciare dai promessi sposi, “il sugo di tutta la storia” non è certo il meglio.