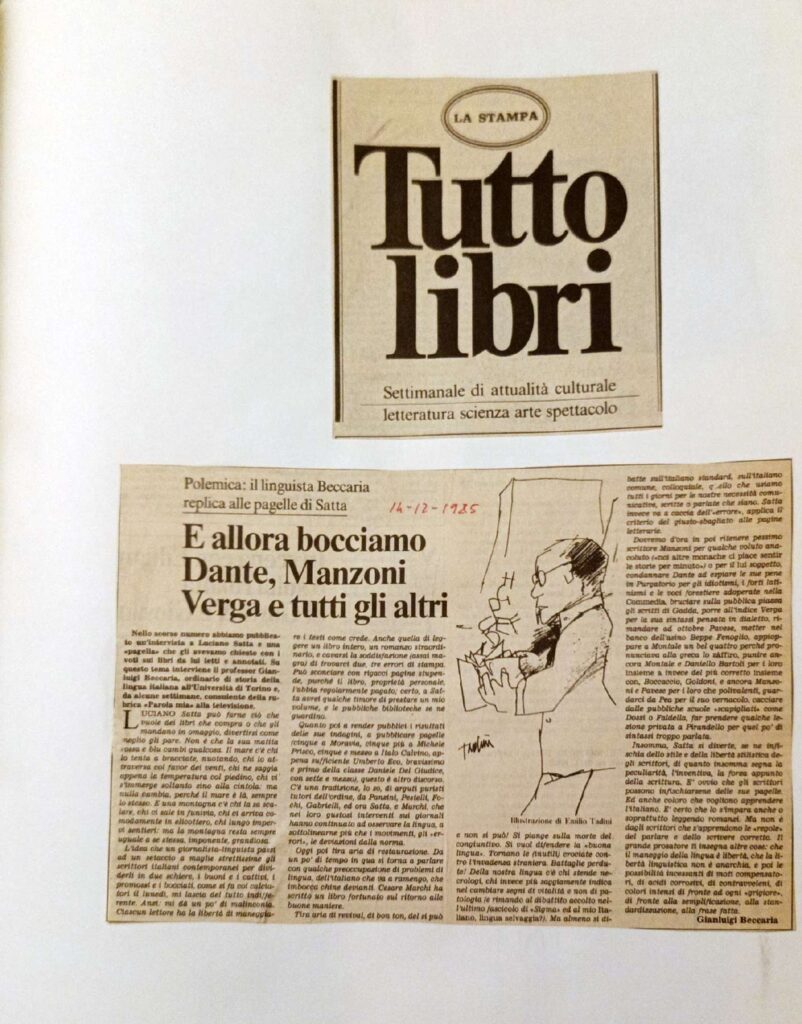«Tuttolibri» 7 dicembre 1985 Agli scrittori io dò la pagella Luciano Satta
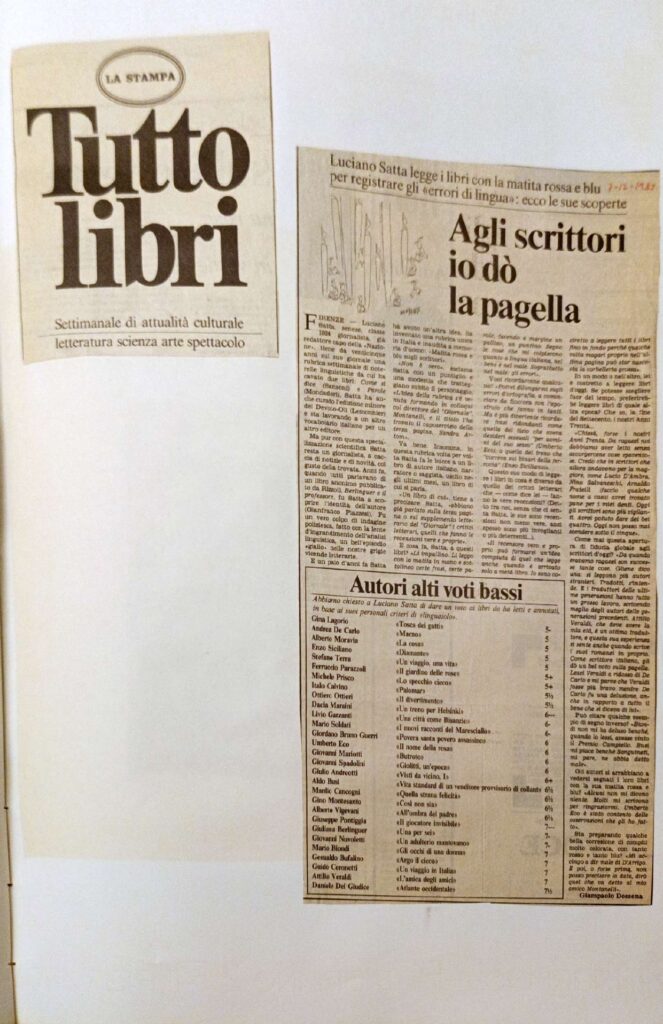
«Tutto libri» 14 dicembre 1985
Polemica: il linguista Beccaria replica alle pagelle di Satta
E allora bocciamo Dante, Manzoni e tutti gli altri Gianluigi Beccaria
Nello scorso numero abbiamo pubblicato un’intervista a Luciano Satta e una «pagella» che gli avevamo chiesto con i voti sui libri da lui letti e annotati. Su questo tema interviene il professor Gianluigi Beccaria, ordinario di storia della lingua italiana all’Università di Torino e, da alcune settimane, consulente della rubrica «Parola mia» alla televisione.
Luciano Satta può farne ciò che vuole dei libri che compra o che gli mandano in omaggio, divertirsi come meglio gli pare. Non è che la sua matita blu o rossa cambi qualcosa. Il mare c’è chi lo tenta a bracciate nuotando, chi lo attraversa col favor dei venti, che ne saggia appena la temperatura col piedino, chi vi s’immerge soltanto sino alla cintola: ma nulla cambia, perché il mare è là, sempre lo stesso. E una montagna c’è chi la sa scalare, chi ci sale in funivia, chi ci arriva comodamente in elicottero, chi lungo impervi sentieri: ma la montagna resta sempre uguale a se stessa, imponente, grandiosa.
L’idea che un giornalista-linguista passi ad un setaccio a maglie strettissima gli scrittori italiani contemporanei per dividerli in due schiere, i buoni e i cattivi, i promossi e i bocciati, come si fa coi calciatori il lunedì, mi lascia del tutto indifferente. Anzi: mi dà un po’ di malinconia. Ciascun lettore ha la libertà di maneggiare i testi come crede. Anche quella di leggere un libro intero, un romanzo straordinario, e cavarsi la soddisfazione (assai magra) di trovarci due, tre errori di stampa. Può sconciare con rigacci pagine stupende, purchè il libro, proprietà personale, l’abbia regolarmente pagato; certo a Satta avrei qualche timore a prestare un mio volume, e le pubbliche biblioteche se ne guardino.
Quanto poi a rendere pubblici i risultati delle sue indagini, a pubblicare pagelle (cinque a Moravia, cinque più a Michele Prisco, cinque e mezzo a Italo Calvino, appena sufficiente Umberto Eco, bravissimo e primo della classe Daniele Del Giudice, con sette e mezzo), questo è un altro discorso. C’è una tradizione, lo so, di arguti puristi tutori dell’ordine, da Panzini, Pestelli, Fochi, Gabrielli, ed ora Satta, e Marchi, che nei loro gustosi interventi sui giornali hanno continuato ad osservare la lingua, a sottolinearne più che i movimenti, gli «errori», le deviazioni dalla norma.
Oggi poi tira aria di restaurazione. Da un po’ di tempo in qua si torna a parlare con qualche preoccupazione di problemi di lingua, dell’italiano che va a ramengo, che imbocca chine devianti. Cesare Marchi ha scritto un libro fortunato sul ritorno alle buone maniere.
Tira aria di revival, di bon ton, del si può o non si può! Si piange sulla morte del congiuntivo. Si vuol difendere la «buona lingua». Tornano le (inutili) crociate contro l’invadenza straniera. Battaglie perdute! Della nostra lingua c’è chi stende necrologi, chi invece più saggiamente indica nel cambiare segni di vitalità e non di patologia (e rimanda al dibattito accolto nell’ultimo fascicolo di «Sigma» ed al mio Italiano, lingua selvaggia?). Ma almeno si dibatte sull’italiano standard, sull’italiano comune, colloquiale, quello che usiamo tutti i giorni per le nostre necessità comunicative, scritte o parlate che siano. Satta invece va a caccia dell’«errore», applica il criterio del giusto-sbagliato alle pagine letterarie.
Dovremo d’ora in poi ritenere pessimo scrittore Manzoni per qualche voluto anacoluto («noi altre monache ci piace sentir le storie per minuto») o per il lui soggetto, condannare Dante ad espiare le sue pene in Purgatorio per i suoi idiotismi, i forti latinismi e le voci forestiere adoperate nella Commedia, bruciare sulla pubblica piazza gli scritti di Gadda, porre all’indice Verga per la sua sintassi pensata in dialetto, rimandare Pavese, metter nel banco dell’asino Beppe Fenoglio, appioppare a Montale un bel quattro perché pronunciava alla greca lo zàffiro, punire ancora Montale e Daniello Bartoli per i loro insieme invece del più corretto insieme con, Boccaccio, Goldoni, e ancora Manzoni e Pavese per i loro che polivalenti, guardarci da Pea per il suo vernacolo, cacciare dalle pubbliche scuole gli «scapigliati», come Dossi o Faldella, far prendere qualche lezione privata a Pirandello per quel po’ di sintassi troppo parlata.
Insomma, Satta si diverte, se ne infischia dello stile e della libertà stilistica degli scrittori, di quanto insomma segna la peculiarità, l’inventiva, la forza appunto della scrittura. È ovvio che gli scrittori possono infischiarsene delle sue pagelle. Ed anche coloro che vogliono apprendere l’italiano. È certo che lo s’impara anche o soprattutto leggendo romanzi. Ma non è dagli scrittori che s’apprendono le «regole» del parlare e dello scrivere corretto. Il grande prosatore ti insegna altre cose: che il maneggio della lingua è libertà, che la libertà linguistica non è anarchia, e poi le possibilità incessanti di molti compensatori, di acidi corrosivi, di contravveleni, di colori intensi di fronte ad ogni «grigiore», di fronte alla semplificazione, alla standardizzazione, alla frase fatta.