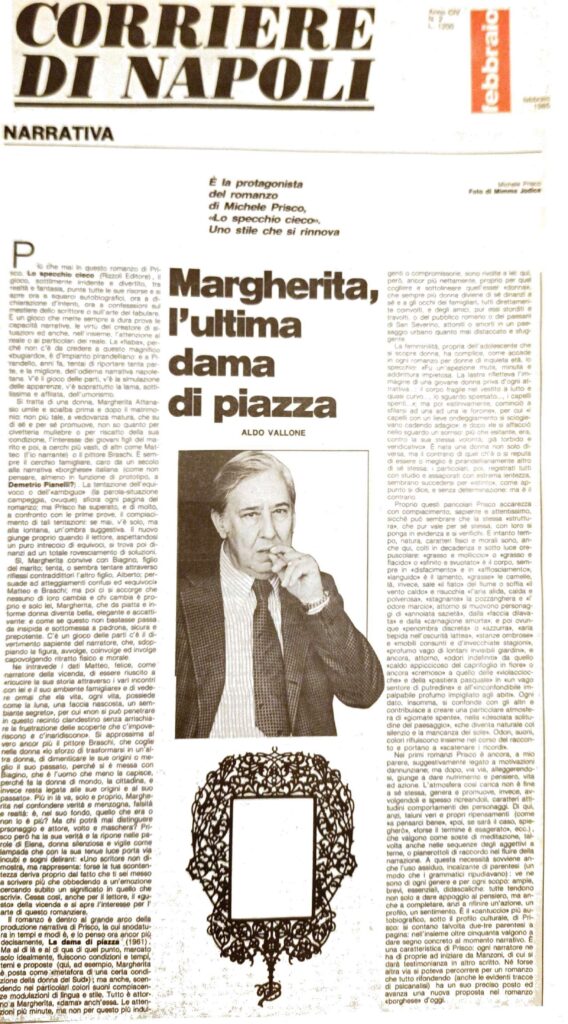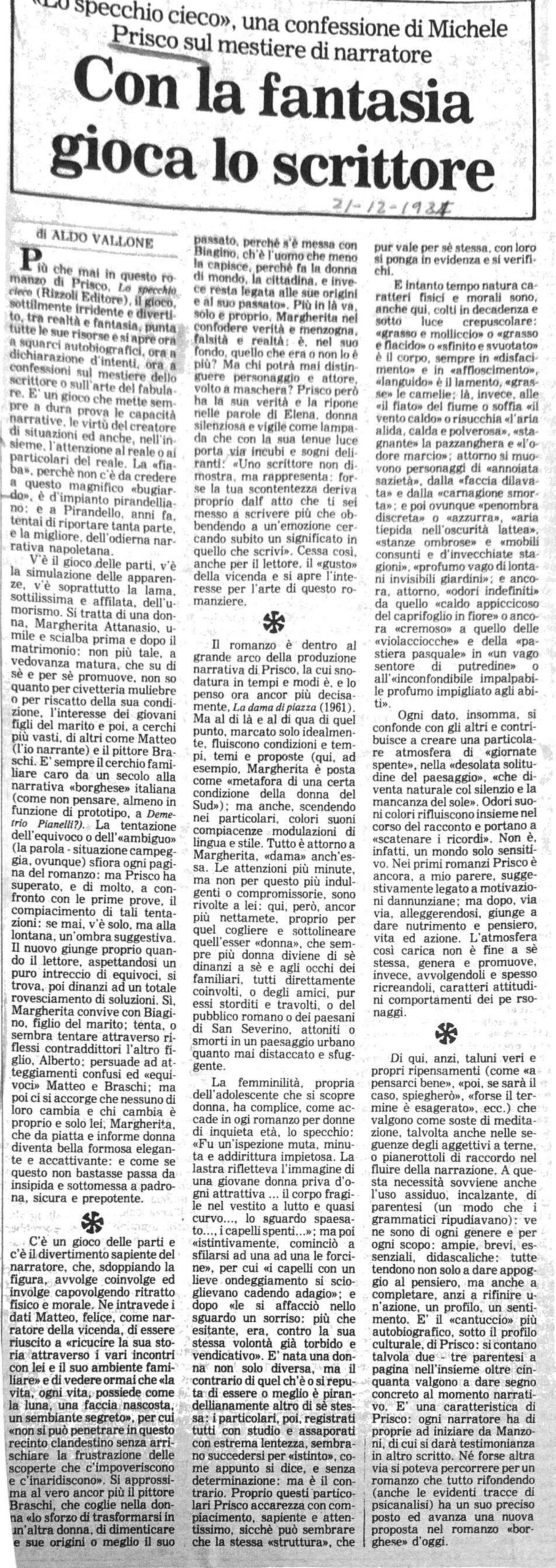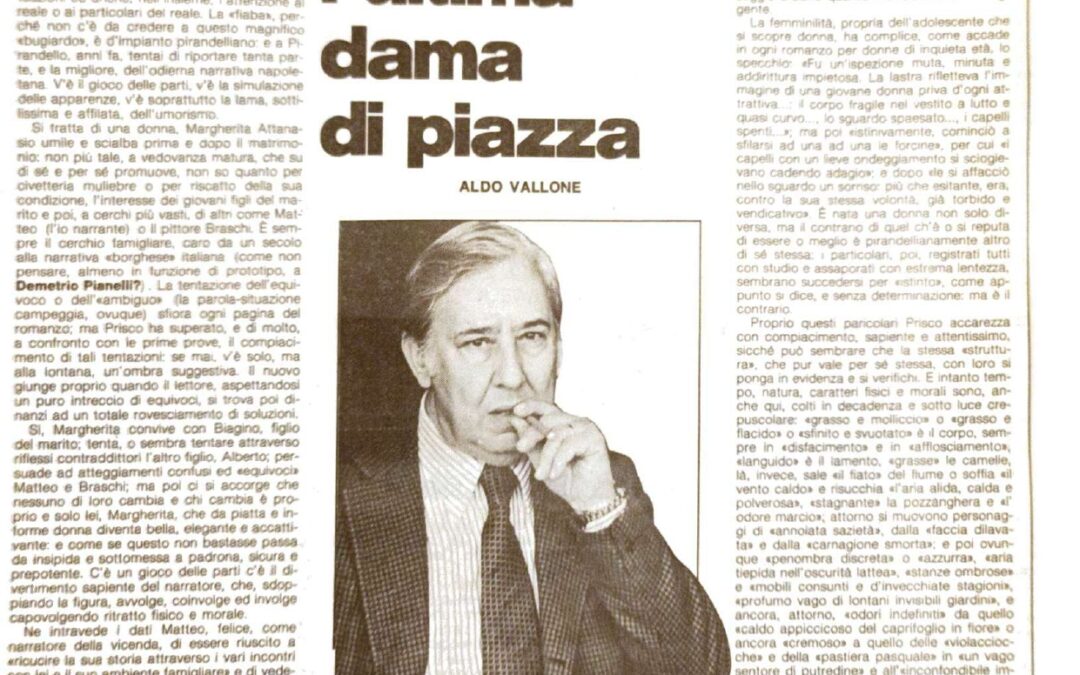Quotidiano di Taranto 21 dicembre 1984 Con la fantasia gioca lo scrittore Aldo Vallone
«Corriere di Napoli» anno CIV n. 2 Margherita, l’ultima dama di Piazza Aldo Vallone
Più che mai in questo romanzo del Prisco, Lo specchio cieco (Rizzoli Editore), il gioco, sottilmente irridente e divertito, tra realtà e fantasia, punta tutte le sue risorse e si apre ora a squarci autobiografici, ora a dichiarazione d’intenti, ora a confessioni sul mestiere dello scrittore o sull’arte del fabulare. É un gioco che mette sempre a dura prova le capacità narrative, le virtù del creatore di situazioni ed anche, nell’insieme, l’attenzione al reale o ai particolari del reale. La «fiaba», perché non c’è da credere a questo magnifico «bugiardo», è d’impianto pirandelliano: e a Pirandello, anni fa, tentai di riportare tanta parte, e la migliore, dell’odierna narrativa napoletana. V’è il gioco delle parti, c’è la simulazione delle apparenze, v’è soprattutto la lama, sottilissima e affilata, dell’umorismo.
Si tratta di una donna, Margherita Attanasio umile e scialba prima e dopo il matrimonio: non più tale, a vedovanza matura, che su di sé e per sé promuove, non so quanto per civetteria muliebre o per riscatto della sua condizione, l’interesse dei giovani figli del marito e poi, a cerchi più vasti, di altri come Matteo (l’io narrante) o il pittore Braschi. É sempre il cerchio famigliare, caro da un secolo alla narrativa «borghese» italiana (come non pensare, almeno in funzione di prototipo, a Demetrio Pianelli?). La tentazione dell’equivoco o dell’«ambiguo» (la parola-situazione campeggia, ovunque) sfiora ogni pagina del romanzo; ma Prisco ha superato, e di molto, a confronto con le prime prove, il compiacimento di tali tentazioni: se mai, v’è solo, ma alla lontana, un’ombra suggestiva. Il nuovo giunge proprio quando il lettore, aspettandosi un puro intreccio di equivoci, si trova poi dinanzi ad un tale rovesciamento di soluzioni.
Sì, Margherita convive con Biagino, figlio del marito; tenta, o sembra tentare attraverso riflessi contraddittori l’altro figlio, Alberto; persuade ad atteggiamenti confusi ed «equivoci» Matteo e Braschi; ma poi ci si accorge che nessuno di loro cambia e chi cambia è proprio e solo lei, Margherita, che da piatta e informe donna diventa bella, elegante e accattivante: e come se questo non bastasse passa da insipida sottomessa a padrona, sicura e prepotente. C’è un gioco delle parti c’è il divertimento sapiente del narratore, che, sdoppiando la figura, avvolge, coinvolge ed involge capovolgendo ritratto fisico e morale.
Ne intravede i dati Matteo, felice, come narratore della vicenda, di essere riuscito a «ricucire attraverso i vari incontri con lei e il suo ambiente famigliare» e di vedere ormai che «la vita, ogni vita, possiede come la luna, una faccia nascosta, un sembiante segreto», per cui non si può penetrare in questo recinto clandestino senza arrischiare la frustrazione delle scoperte che c’impoveriscono e c’inaridiscono». Si approssima al vero ancor più il pittore Braschi, che coglie nella donna «lo sforzo di trasformarsi in un’altra donna, di dimenticare le sue origini o meglio il suo passato, perchè si è messa con Biagino, che è l’uomo che meno la capisce, perché fa la donna di mondo, la cittadina, e invece resta legata alle sue origini e al suo passato». Più in là va, solo e proprio, Margherita nel confondere verità e menzogna, falsità e realtà: è, nel suo fondo, quello che era o non lo è più? Ma chi potrà mai distinguere personaggio e attore, volto e maschera? Prisco però ha la sua verità e la ripone nelle parole di Elena, donna silenziosa e vigile come lampada che con la sua tenue luce porta via incubi e sogni deliranti:«Uno scrittore non dimostra, ma rappresenta: forse la tua scontentezza deriva proprio dal fatto che ti sei messo a scrivere più che obbedendo a un’emozione cercando subito un significato in quello che scrivi». Cessa così, anche per il lettore, il «gusto» della vicenda e si riapre l’interesse per l’arte di questo romanziere.
Il romanzo è dentro al grande arco della produzione narrativa di Prisco, la cui snodatura in tempi e modi è, e lo penso ora ancor più decisamente, La dama di piazza (1961). Ma al di là e al di qua di quel punto, marcato solo idealmente, fluiscono condizioni e tempi, temi e proposte (qui, ad esempio, Margherita è posta come «metafora di una certa condizione della donna del Sud»); ma anche, scendendo nei particolari colori suoni compiacenze modulazioni di lingua e stile. Tutto è attorno a Margherita, «dama» anch’essa. Le attenzioni più minute, ma non per questo più indulgenti o compromissorie, sono rivolte a lei: qui, però, ancor più nettamente, proprio per quel cogliere e sottolineare quell’esser «donna», che sempre più donna diviene di sè dinanzi a sè e agli occhi dei famigliari, tutti direttamente coinvolti, e degli amici, pur essi storditi e travolti, o del pubblico romano o dei paesani di San Severino, attoniti o smorti in un paesaggio urbano quanto mai distaccato e sfuggente.
La femminilità, propria dell’adolescente che si scopre donna, ha complice, come accade in ogni romanzo per donne di inquieta età, lo specchio:«Fu un’ispezione muta, minuta e addirittura impietosa. La lastra rifletteva l’immagine di una giovane donna priva di ogni attrattiva…: il corpo fragile nel vestito a lutto e quasi curvo…, lo sguardo spaesato…, i capelli spenti…»; ma poi «istintivamente, cominciò a sfilarsi ad una ad una le forcine», per cui «i capelli con un lieve ondeggiamento si scioglievano cadendo adagio»; e dopo «le si affacciò nello sguardo un sorriso: più che esitante, era, contro la sua stessa volontà, già torbido e vendicativo». É nata una donna non solo diversa, ma il contrario di quel ch’è o s’era reputa di essere o meglio è pirandellianamente altro di sè stessa: i particolari, poi, registrati tutti con studio e assaporati con estrema lentezza, sembrano succedersi per «istinto», come appunto si dice, e senza determinazione: ma è il contrario.
Proprio questi particolari Prisco accarezza con compiacimento, sapiente e attentissimo, sicché può sembrare che la stessa «struttura»‚ che pur vale per sé stessa, con loro si ponga in evidenza e si verifichi. E intanto tempo, natura, caratteri fisici e morali sono, anche qui, colti in decadenza e sotto luce crepuscolare: «grasso e molliccio» o «grasso e flaccido» o «sfinito e svuotato» è il corpo, sempre in «disfacimento» e in «afflosciamento», languido» è il lamento, «grasse» le camelie, là, invece, sale «il fiato» del fiume o soffia «il vento caldo» e risucchia «l’aria alida, calda e polverosa, «stagnante» la pozzanghera e «l’odore marcio»; attorno si muovono personaggi di «annoiata sazietà», dalla «faccia dilavata» e dalla «carnagione smorta»; e poi ovunque «penombra discreta» o «azzurra», «aria tiepida nell’oscurità lattea», «stanze ombrose» e «mobili consunti e d’invecchiate stagioni», «profumo vago di lontani invisibili giardini», e ancora, attorno, «odori indefiniti» da quello «caldo e appiccicoso del caprifoglio in fiore» o ancora «cremoso» a quello delle «violacciocche» e della «pastiera pasquale» in «un vago sentore di putredine» e all’«inconfondibile impalpabile profumo impigliato agli abiti». Ogni dato, insomma, si confonde con gli altri e contribuisce a creare una particolare atmosfera di «giornate spente», nella «desolata solitudine del paesaggio», «che diventa naturale col silenzio e la mancanza del sole». Odori, suoni, colori rifluiscono insieme nel corso del racconto e portano a «scatenare i ricordi».
Nei primi romanzi Prisco è ancora, a mio parere, suggestivamente legato a motivazioni dannunziane; ma dopo, via via, alleggerendosi, giunge a dare nutrimento e pensiero, vita ed azione. L’atmosfera così carica non è fine a sè stessa, genera e promuove, invece, avvolgendoli e spesso ricreandoli, caratteri attitudini comportamenti dei personaggi. Di qui, anzi, taluni veri e propri ripensamenti (come «a penarci bene», «poi, se sarà il caso, spiegherò», «forse il termine è esagerato», ecc.), che valgono come soste di meditazione, talvolta anche nelle sequenze degli aggettivi a teme, o pianerottoli di raccordo nel fluire della narrazione. A questa necessità sovviene anche l’uso assiduo, incalzante di parentesi (un modo che i grammatici ripudiavano): ve ne sono di ogni genere e per ogni scopo: ampie, brevi, essenziali, didascaliche: tutte tendono non solo a dare appoggio al pensiero, ma anche a completare, anzi a rifinire un’azione, un profilo, un sentimento. É il «cantuccio» più autobiografico, sotto il profilo culturale, di Prisco: si contano talvolta due-tre parentesi a pagina: nell’insieme oltre cinquanta valgono a dare segno concreto al momento narrativo. É una caratteristica di Prisco: ogni narratore ne ha di proprie a iniziare da Manzoni, di cui si darà testimonianza in un altro scritto. Né forse altra via si poteva percorrere per un romanzo che tutto rifondendo (anche le evidenti tracce di psicanalisi) ha un suo preciso posto ed avanza una nuova proposta nel romanzo «borghese» d’oggi.