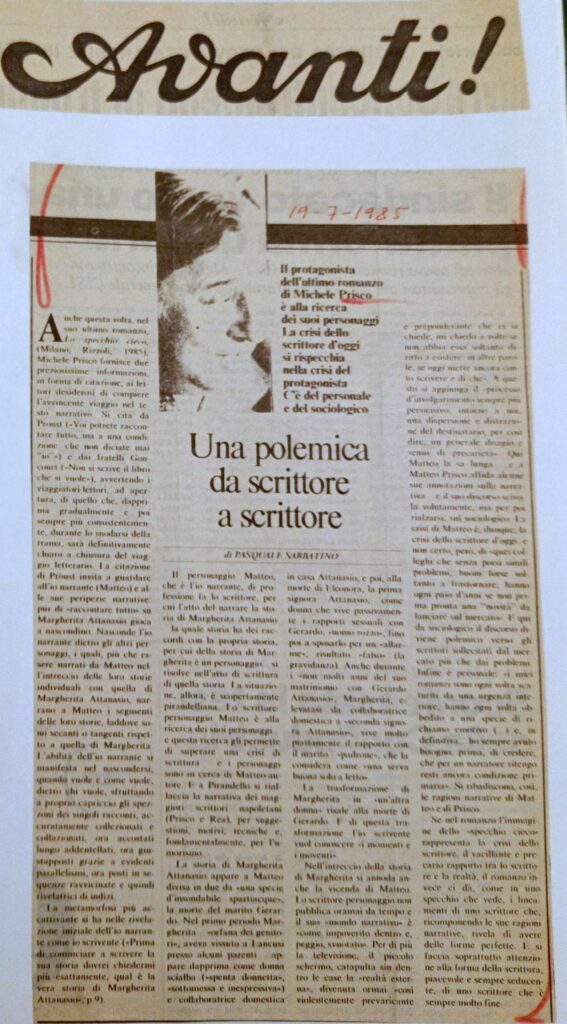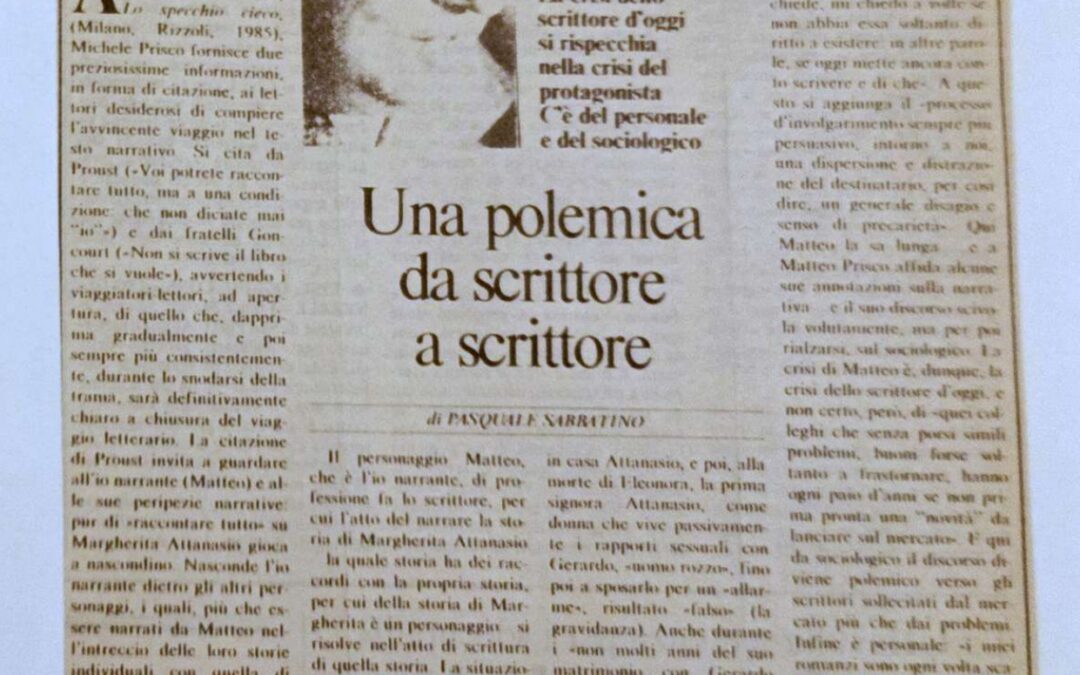«Avanti» 19 luglio 1985 Una polemica da scrittore a scrittore Pasquale Sabbatino
Anche questa volta, nel suo ultimo romanzo, Lo specchio cieco, (Milano, Rizzoli, 1985), Michele Prisco fornisce due preziosissime informazioni, in forma di citazione, ai lettori desiderosi di compiere l’avvincente viaggio nel testo narrativo. Si cita da Proust (“voi potete raccontare tutto, ma a una condizione che non diciate mai ‘io’”) e dai fratelli Goncourt (“non si scrive il libro che si vuole”), avvertendo i viaggiatori lettori, ad apertura, di quello che, dapprima gradualmente e poi sempre più consistentemente, durante lo snodarsi della trama, sarà definitivamente chiaro a chiusura del viaggio letterario. La citazione di Proust invita a guardare all’io narrante (Matteo) e alle sue peripezie narrative pur di “raccontare tutto” su Margherita Attanasio gioca a nascondino. Nasconde l’io narrante dietro gli altri personaggi, i quali, più che essere narrati da Matteo nell’intreccio delle loro storie individuali con quella di Margherita Attanasio, narrano a Matteo i segmenti delle loro storie, laddove sono secanti o tangenti rispetto a quella di Margherita. L’abilità dell’io narrante si manifesta nel nascondersi, quando vuole e come vuole, dietro chi vuole, sfruttando a proprio capriccio gli spezzoni dei singoli racconti, accuratamente collezionati e collazionati, ora accostati lungo addentellati, ora giustapposti grazie a evidenti parallelismi, ora posti in sequenze ravvicinate e quindi rivelatrici di indizi.
La metamorfosi più accattivante si ha nella rivelazione iniziale dell’io narrante come io scrivente (“Prima di cominciare a scrivere la sua storia dovrei chiedermi più esattamente, qual è la vera storia di Margherita Attanasio”, p. 9).
Il personaggio Matteo, che è l’io narrante, di professione fa lo scrittore, per cui l’atto del narrare la storia di Margherita Attanasio, la quale storia ha dei raccordi con la propria storia, per cui nella storia di Margherita è un personaggio si risolve nell’atto di scrittura di quella storia. La situazione, allora, è scopertamente pirandelliana. Lo scrittore personaggio Matteo è alla ricerca dei suoi personaggi e questa ricerca gli permette di superare una crisi di scrittura e i personaggi sono in cerca di Matteo autore. E a Pirandello si riallaccia la narrativa dei maggiori scrittori napoletani (Prisco e Rea), per suggestioni, motivi, tecniche e, fondamentalmente, per l’umorismo,
la storia di Margheria Attanaio appare a Matteo divisa in due da “una specie d’insondabile spartiacque”, la morte del marito Gerardo. Nel primo periodo Margherita Attanasio “orfana dei genitori”, aveva vissuto a Lancusi presso alcuni parenti, appare dapprima come donna scialba (“spenta donnetta”, “sottomessa e inespressiva”) e collaboratrice domestica in casa Attanasio, e poi, alla morte di Eleonora, la prima signora Attanasio, come donna che vive passivamente i rapporti sessuali con Gerardo, “uomo rozzo”, fino poi a sposarlo per un “allarme” risultato “falso” (la gravidanza). Anche durante i “non molti anni del suo matrimonio con Gerardo Attanasio”, Margherita, elevatasi da collaboratrice domestica a “seconda signora Attanasio”, vive molto piattamente il rapporto con il marito “padrone”, che la considera come “una serva buona solo a letto”.
La trasformazione di Margherita in un’altra donna risale alla morte di Gerardo. E di questa trasformazione l’io scrivente vuol conoscere “i momenti e i moventi”.
Nell’intreccio della storia Margherita si annoda anche la vicenda di Matteo. Lo scrittore personaggio non pubblica oramai da tempo e il suo “mondo narrativo” è “come impoverito dentro e, peggio, svuotato”. Per di più la televisione, il piccolo schermo, catapulta sin dentro le case la “realtà esterna”, divenuta ormai “così violentemente prevaricante e preponderante che ci si chiede, mi chiedo a volta se non abbia essa soltanto diritto a esistere in altre parole, se oggi mette ancora conto scrivere e di che – A questo si aggiunga il processo d’involgarimento sempre più persuasivo, intorno a non una dispersione e distrazione del destinatario, per così dire, un generale disagio e senso di precarietà”. Qui Matteo la sa lunga e a Matteo Prisco affida alcune sue annotazioni sulla narrativa e il suo discorso scivola volutamente, ma per poi rialzarsi, sul sociologico. La crisi di Matteo è, dunque, la crisi dello scrittore d’oggi, e non certo, però, di “quei colleghi che senza problemi, buoni forse soltanto a frastornare, hanno ogni paio d’anni se non prima pronta una “novità” da lanciare sul mercato”. E qui da sociologico il discorso diviene polemico verso gli scrittori sollecitati dal mercato più che dai problemi. Infine è personale” i miei romanzi sono ogni volta scaturiti da una urgenza interiore, hanno ogni volta obbedito a una specie di richiamo emotivo (…) e, in definitiva, ho sempre avuto bisogno, prima, di credere, Ehi che per un narratore ritengo resti ancora condizione primaria”. Si ribadiscono, così, le ragioni narrative di Matteo e di Prisco.
Se nel romanzo l’immagine dello “specchio cieco” rappresenta la crisi dello scrittore, il vacillante e precario rapporto tra lo scrittore e la realtà il romanzo invece ci dà, come in uno specchio che vede , i lineamenti di uno scrittore che, ricomponendo le sue ragioni narrative, rivela di avere delle forme perfette. E si faccia soprattutto attenzione alla forma della scrittura, piacevole e sempre seducente, di uno scrittore che è sempre molto fine.